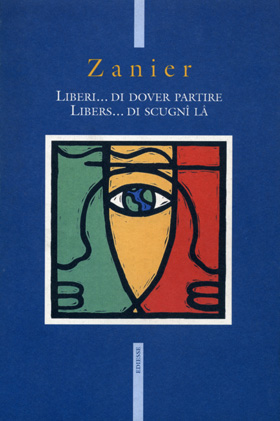| |
Gli scrittori della Svizzera italiana
Autori della Svizzera di lingua italiana
Autore: Prof. Dr. Jean-Jacques Marchand, Svizzera
Responsabile scientifico: Dr. Sacha Zala, Svizzera
Referente didattico: Prof.ssa Michela Nocita, Italia
Due patrie una comune cultura
Sebbene separati per secoli da una frontiera politica dal resto degli stati italiani, il Ticino e le quattro valli italofone dei Grigioni, sono sempre rimasti in stretto rapporto culturale con la vicina Italia, prima e dopo l’Unità. L’identità che la minoranza italofona svizzera sta dandosi all’interno della Confederazione nell’Otto e nel Novecento implica anche il riconoscimento di una letteratura propria, seppur appartenente alla più ampia cultura italiana.
Italianità ed elveticità tra Otto e primo Novecento
Due autori rappresentano due modelli di comportamento sia culturale che politico nei confronti dell’Italia tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Schematizzando un po’, si può dire che il primo, Francesco Chiesa (1871-1973), che influenzò la vita culturale ticinese per quasi un secolo, rappresenta quella schiera di intellettuali attratti tanto dalla tradizione culturale italiana quanto dalle gratificazioni che derivavano da tale schieramento al punto di chiudere gli occhi sui soprusi del regime fascista (1921-1945). Francesco Chiesa esordisce nel 1897 con una raccolta poetica, Preludio, di gusto decadente (pubblicata in Italia), seguita poco dopo da Calliope, in cui si avvicina ad una poesia colta di tipo carducciano. Sebbene queste raccolte gli aprano le porte del mondo culturale italiano, si orienta a partire dagli anni Venti verso la scrittura in prosa, con tre volumi Racconti puerili (1921), Tempo di marzo (romanzo) (1925) e Racconti del mio orto (1928). In queste raccolte, sulla linea di un tardo verismo, segnato dalla ricerca di una prosa d’arte, secondo i modelli lombardi di Linati, Lucini e Serra, Chiesa compone piccoli bozzetti che ritraggono personaggi e situazioni del Ticino rurale dell’ultimo Ottocento, in una lingua ricca di lombardismi e di toscanismi, in uno spirito di bonarietà paternalistica e benpensante ereditata dal tardo manzonismo piccolo borghese. L’altra figura di spicco, Giuseppe Zoppi (1896-1952), ardente difensore di un’identità svizzera multilinguistica senza compromessi ideologici, è volta maggiormente all’evocazione dei valori ideali della Svizzera, come la natura incontaminata, l’elevazione spirituale, la schiettezza dei sentimenti, la probità intellettuale. La sua opera più nota è una raccolta di brevi prose d’arte intitolata Il libro dell’alpe (uscito, pure in Italia, nel 1922), in cui vengono descritte le sensazioni e le riflessioni che un cittadino può provare nel recarsi su un pascolo di montagna. Il paesaggio è, per lui, luogo di elevazione e di ricerca di un candore incontaminato, la cui evocazione richiede l’uso di una prosa fortemente poetica.
Tra Dante e Goethe – gli anni Cinquanta e Sessanta
Sebbene uno svecchiamento della letteratura italiana in Svizzera fosse già in atto fin dagli anni Trenta-Quaranta, grazie anche a riviste come “Quaderni grigionitaliani”1 (1931) e “Svizzera italiana” (1941), create per reazione all’irredentismo del regime fascista, una nuova generazione di poeti e di narratori nascerà in Svizzera italiana soprattutto grazie alla conoscenza di voci nuove della poesia e della prosa italiana, promossa da G.B. Angioletti e da G.F. Contini in Ticino e da F. Menghini nel Grigioni italiano fin dagli anni Quaranta.
Giorgio Orelli (1922) dà il via, fin dal 1944, con la raccolta Né bianco né viola, al nuovo corso della poesia in Ticino: l’esile plaquette confluirà nel 1962 nella prima grande raccolta L’ora del tempo (1962); seguiranno Sinopie (1977), Spiracoli (1989), Il collo dell’anitra (2001). La sua opera nasce nell’alveo del postermetismo, e di Montale in particolare, che agisce da filtro rispetto alla tradizione ottocentesca di Pascoli e Carducci. Nella linea delle “occasioni” montaliane, i suoi componimenti nascono dall’osservazione di particolari della vita (umana, animale, vegetale) che suscitano splendide “illuminazioni” o profonde riflessioni, segnate da un costante senso morale. È una poesia fortemente colta, sia nella metrica, sia nella tecnica dell’incastonamento di citazioni e rinvii alla tradizione letteraria più illustre, Dante in particolare, e ai Moderni, Montale ovviamente, ma anche Goethe e Gottfried Benn. In Sinopie e Spiracoli i versi si espandono maggiormente fino ad aprirsi ad una forma di narrazione, mentre subentra una maggiore autoironia. Più frequenti sono nelle ultime raccolte anche i dialettismi, le forme regionali dell’italiano, e addirittura le parole straniere (in particolare il tedesco).
Una poesia altrettanto colta, anch’essa ricca di riferimenti al modello dantesco, è quella del grigionese Remo Fasani (1922). Esordisce anche lui alla metà degli anni Quaranta con Senso dell’esilio (1945). I componimenti del quarantennio seguente, pubblicati in varie “plaquettes” vengono raccolti in Le Poesie (1941-1986). Seguono varie raccolte, anche di prose, tra cui: Giornale minimo (1993), Sonetti morali (1995) e A Sils Maria nel mondo (2000). Nella sua poesia si alternano fasi molto raffinate, di poesia quasi lapidaria, come le quartine ispirate alla lirica cinese, e fasi di forte impegno civile e morale, in difesa dell’italianità in Svizzera, del rispetto della natura e dell’etica in politica, caratterizzate dal ricorso ad un lessico concreto e ad un andamento discorsivo del verso.
Una terza via è rappresentata dal grigionese Grytzko Mascioni (1936-2003), autore di narrazioni, fra saggio ed autobiografia, di un perenne viaggio tra luoghi topici e miti dell’Antichità, e poeta, ispirato, più che da Montale, da una ampia tradizione postsimbolista, con forti presenze di poeti classici. Dopo la sua prima “plaquette” intitolata Vento a primavera (1953), una raccolta cumulativa del 1984, Poesia (1952-1982) presenta un’ampia antologia dei componimenti pubblicati in quel trentennio. Seguiranno due romanzi, vari saggi-racconti e numerose raccolte di poesie. I luoghi sono quelli dei suoi viaggi, le persone illustri ed anonime incontrate nella sua attività di giornalista, donne anche, alle quali vengono rivolti omaggi raffinati e galanti; predomina il dialogo, da cui si ritrae una filosofia della vita edonista, seduttrice e scettica. Diverse sono le raccolte dell’ultimo decennio: Ex Ilyrico tristia (1994), una serie di componimenti sulla guerra serbo-croata, segnati dal dolore, dallo stupore e dalla protesta, e Angstbar (2003), in cui il poeta, spogliatosi della maschera mondana nell’imminenza della morte, cerca un’ultima consolazione in una presenza femminile.
Sul versante della prosa, un nome si è imposto sin dagli anni Sessanta, anche presso importanti editori italiani: quello di Giovanni Orelli (1928), che verrà poi riconosciuto anche in quanto poeta, per lo più dialettale. I romanzi, ambientati in Svizzera: L’anno della valanga (1965), La festa del ringraziamento (1992), Il gioco del Monopoly (1980), Il sogno di Walacek (1991), Gli occhiali di Lorelieff (2000),... s’inseriscono nella linea del romanzo realista del dopoguerra, in cui l’intento di denuncia sociale e di impegno civile viene mediato letterariamente da una ricerca sempre nuova di voci narranti (ora l’io del protagonista, ora un noi corale, ora una terza persona esterna alla vicenda).
Armonia e disagio – dagli anni Settanta a Novanta
Su un piano più metafisico, seppur non privo di impegno civile, si colloca la poesia di Gilberto Isella (1943). Giocata su richiami dotti, su interferenze fra ritmi, sonorità e scandagli psicologici, su visioni e scontri con un mondo difficile da decriptare, l’opera si dipana in successivi canzonieri dai titoli ad un tempo enigmatici e rivelatori come Le vigilie incustodite (1989), Discordo (1993), Apoteca (1996), Nominare il caos (2001), Taglio di mondo (2007).
La poesia di Fabio Pusterla (1954) è di tipo molto più espressionista: l’autore suggerisce, attraverso segmenti di paesaggio e ritratti brevi, ora una situazione di disagio di fronte al mondo moderno, ora di possibile riscatto in una forma di coralità o di sentimento di armonia con i luoghi. Questa apertura verso il superamento è sensibile osservando l’evoluzione della sua poesia da Concessione all’inverno (1985) e Bocksten (1989) a Le cose senza storia (1994) e Le terre emerse (2009).
Autori italiani residenti in Svizzera
Un filone particolare della letteratura di lingua italiana in Svizzera è costituito dalle opere scritte da italiani giunti in Svizzera con il grande flusso migratorio degli anni Sessanta-Settanta del Novecento. Fra la settantina di autori, che pubblicarono più di 200 opere, due almeno vanno segnalati: Leonardo Zanier (1935) e Saro Marretta (1940). Il primo, dopo avere iniziato con una poesia in cui il forte impegno politico e civile era già mediato dall’uso della lingua friulana (Libers di scugní lâ / Liberi di dover partire: 1964), è approdato presto ad una lirica filosofica, segnata dall’ironia, dai giochi verbali e dalla commistione dei registri linguistici (Il câli, 1989, Usmas, 1991; Suscipe caelum, 1999). Saro Marretta ha pure usato il doppio registro dell’italiano e del dialetto siciliano per rappresentare, ora in prosa (giocata sull’umorismo e lo stile diretto: Piccoli italiani in Svizzera, 1968), ora in poesia (segnata da un’espressione densa e contenuta del dolore: Agli, 1982), la durezza dell’esperienza migratoria.
Le giovani leve
Fra i giovani che si sono affermati nell’ultimo decennio, due poeti posso essere rappresentativi di nuove tendenze. Il primo, Vanni Bianconi (1977), s’inserisce nella scia di Fabio Pusterla, dal quale raccoglie la filiazione montaliana; ma nella sua poesia sono presenti anche stilemi sereniani e motivi derivati dalla poesia anglosassone contemporanea. Da un confronto fra la prima raccolta, Faura di morti (2004) e la seconda Ora prima (2008), possiamo notare una progressiva liberazione dai modelli della tradizione lombarda ed una apertura a forme di tipo narrativo. Nel secondo, Oliver Scharpf (1977), la lingua parlata è una caratteristica prevalente della sua poesia, come indicano i titoli stessi delle raccolte: uppercuts (2004) e la durata del viaggio dell’olive nel martinicocktail (2007). Ispirandosi a forme di comunicazione moderna, Scharpf ricerca la resa dell’istante, del fuggevole, dell’immediato con tecniche che ricordano quelle della Neoavanguardia.
In conclusione, pur facendo parte della letteratura italiana in senso lato, le opere degli autori di lingua italiana in Svizzera sono caratterizzate da certe peculiarità, che l’accresciuta osmosi fra i due paesi ha notevolmente attenuato negli ultimi decenni.
L’essenziale in breve
La Svizzera italiana, che si compone dei territori italofoni del Ticino e del Grigioni italiano, ma anche di tutte le persone che parlano italiano in Svizzera fuori dai territori tradizionali della Svizzera italiana, ha dato vita ad una propria letteratura in lingua italiana. Gli scrittori della Svizzera italiana sono sempre rimasti in stretto rapporto culturale con la vicina Italia, prima e dopo l’Unità. L’identità che la minoranza italofona svizzera si diede all’interno della Confederazione nell’Otto e nel Novecento implicò anche il riconoscimento di una prorpia letteratura, seppur appartenente alla più ampia cultura italiana.
Bibliografia:
• G. ORELLI, Svizzera italiana, Brescia, La Scuola, 1986; AA. VV., Dizionario delle letterature svizzere, Locarno, Dadò, 1991
• J.-J. MARCHAND, Le opere in lingua italiana scritte nel secondo dopoguerra da autori italiani in Svizzera, in AA. VV, Gli italiani in Svizzera, a cura di E. Halter, Bellinzona, Casagrande, 2003, pp. 271-81
• R. CASTAGNOLA – L. CIGNETTI, Di soglia in soglia. Venti nuovi poeti nella Svizzera italiana, Lugano, Biblioteca cantonale, 2008; www.unil.ch/poesit.
Letture consigliate:
• G. BONALUMI – R. MARTINONI – P.V. MENGALDO, Svizzera italiana, cit.; Cento anni di poesia nella Svizzera italiana, Locarno, Dadò, 1997;
• A. e M. STÄUBLE, Scrittori del Grigioni italiano, Locarno-Coira, Dadò-Pgi, 20082
• Dizionario storico svizzero (www.dss.ch): voci Letteratura italiana; Chiesa Francesco, Mascioni Grytzko, Zoppi Giuseppe.
[1] Accessibile online a partire dal n. 1/1931: http://qgi.pgi.ch
|
|